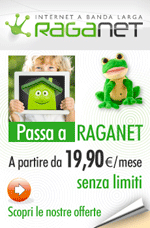Modalità di navigazione
Accesso rapido
Sezioni presenti sul sito
Eventi e speciali
La primavera dei popoli

Musicultura 2011. IV Edizione
Appartiene a...
Informazioni utili
- Categoria: Rassegne
- Data: 16/06/2011
- Indirizzo: Lecce-Teatrino ex Convitto Palmieri
- Orario: Vedi descrizione singolo evento
- Organizzatori: Conservatorio Musicale Tito Schipa
- Telefono: 0832 344266
- Fax: 0832 340951
- E-mail: segreteria@conservatoriolecce.it
- Sito web: http://www.conservatoriolecce.it
“LA PRIMAVERA DEI POPOLI”
I moti del 1848
G. MELILLI – G. GIZZI , Inno composto da studenti toscani volontari nella guerra I d’Indipendenza (1848, e ripreso nel 1891)
Ore 18.00 – Relazione
“Il 1848 in Puglia”
Riccardo Riccardi giornalista e saggista
autore del libro
L’impresa di Felice Garibaldi e il Risorgimento in Puglia (1835-1861) Congedo Editore
Ore 18.30 – Concerto
PROGRAMMA
FRANZ LISZT (Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1886)
Rapsodia ungherese n. 3
Funérailles (october 1849)
da “Harmonies poétiques et religieuses”
Rapsodia ungherese n. 13
Reminiscenze dalla “Norma” di Bellini
Roberto Corlianò
pianoforte
pianoforte
ROBERTO CORLIANÒ, pianista, ha studiato con Fabrizio Garilli presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, diplomandosi nel 1988 presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. A dodici anni ha interpretato la parte di Giuseppe Verdi nell’omonimo sceneggiato televisivo diretto da Renato Castellani. A quattordici anni ha esordito con l’orchestra dell’Angelicum di Milano e, a sedici, in “Sala Verdi” ha interpretato la Fantasia Ungherese di Liszt. Nello stesso anno ha vinto il 1° premio ai Concorso di Musica da Camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni (1° clarinetto solista della Filarmonica della Scala), con il quale ha tenuto numerosi concerti. A diciassette anni la sua esecuzione della Totentanz di Lizst in “Sala Verdi” con l’Orchestra della RAI di Milano ha riscosso entusiastici consensi di pubblico e di critica. Ha conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Pescarese sotto la guida di Michele Marvulli, e ha seguito anche i corsi di direzione d’orchestra del grande Marco Gusella. Ha tenuto recital e concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri, tra i quali: “Sala Verdi” (Milano), “Arts Accademy” (Roma), “Auditorium RAI” (Torino), “Teatro Grande” (Brescia), “Hofburg Bosendorf Saal” (Vienna), “Mozarteum” (Salisburgo), “Places des Arts” (Montreal), “Salle Cortot” (Parigi), “Alice Tully Hall” (New York), “Teatro Ponchielli” (Cremona), “Teatro Municipale” (Piacenza), “Teatro Argentina” (Roma), “Teatro Brancaccio” (Roma), “Teatro Politeama e Teatro Paisiello” (Lecce), “Teatro Giordano” (Foggia), “Teatro Valli” (Reggio Emilia), “Teatro Filarmonico” (Verona), “Hofburg” e “Bosendorfer Saal” (Vienna), “Salle Maisonneuve” (Montreal), “Steinway Hall” e “Alice Tully Hall” (New York), “Smetana Hall” (Praga), “Salle Cortot” (Parigi), “Sunport Hall” (Takamatsu, Giappone). Ha partecipato a circa 150 concorsi nazionali e internazionali piazzandosi sempre ai primi posti. Tra i più importanti, il 1° premio al “Neglia” di Enna, il 3° premio al “Viotti” di Vercelli, il 1° premio allo “Chopin” di Roma, il 1° premio a Lamezia Terme, il 1° premio al “Lions” di Vienna, il 1° premio al “M. P. Monopoli” di Barletta, il 1° premio al “Città di Sulmona”, il 1° premio allo “Speranza” di Taranto, il 1° premio al “Benedetto XIII” di Gravina e il 1° premio e premio del pubblico al “Città di Cantù”. È apparso come solista con diverse orchestre, quali “Angelicum”, “Pomeriggi Musicali” e “RAI” di Milano, “Filarmonica Marchigiana”, “Sinfonica di Bari”, “Sinfonica T. Schipa” di Lecce, “Orchestra della Magna Grecia” di Taranto, “Orchestra della Radiotelevisione” di Lubiana, “Dvorak Praga Synphony Orchestra”, “Sinfonica di Bacau”, “Sinfonica di Plojest”, “Sinfonica di Craiova”, sotto la direzione di illustri direttori, da M. Marvulli a M. Pradella, A. Nanut, E. Boncompagni, V. Mariozzi, O. Balan, M. Beroff, P. Mianiti. Nel 2001 gli è stata consegnata la Coppa del Presidente della Repubblica Italiana per meriti artistici. Attivo anche come camerista, si è più volte esibito in quintetto con i “Solisti della Scala” di Milano e in duo con i violinisti Kaori Ogasawara e Franco Mezzena. Con quest’ultimo ha effettuato un concerto trasmesso in diretta radiofonica RAI3 dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Musicista eclettico, affianca all’attività solistica quella di compositore di “falsi d’autore” e proprie parafrasi, ricalcando la tradizione pianistica dell’800, nonché di pianista accompagnatore, collaborando regolarmente con il noto soprano Katia Ricciarelli. È spesso invitato in giurie di concorsi nazionali e internazionali e tiene Master Class in Italia e all’estero. Le sue esibizioni in Giappone sono state accolte da entusiastici consensi di pubblico e di critica. È titolare di cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.
RICCARDO RICCARDI, giornalista e saggista pugliese di antiche origini lucane, si dedica da molti anni alla ricerca storica privilegiando soprattutto gli aspetti politici ed economici del Mezzogiorno in Età moderna e contemporanea. Ha pubblicato I Pomarici - Storia di un’antica famiglia meridionale (Levante, 2003), I Pomarici di Matera - Vicende di un casato e di un palazzo (Levante, 2006), L’impresa di Felice Garibaldi - Il fratello dell’eroe dei due mondi (1835-1861) (Congedo, 2007), Album Lucano - Personaggi, famiglie e immagini ritrovate (Antezza, 2008). Collabora con le riviste “Risorgimento e Mezzogiorno” dell’Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Bari, con “Studi Bitontini” per il Centro Ricerche di Storia e Arte Bitonto, con il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. È socio del Comitato Pugliese per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
La seconda edizione del volume L’impresa di Felice Garibaldi (2010) analizza lo spaccato economico e politico sia di Nizza, patria dei Garibaldi, sia dell’intera provincia di Bari e, soprattutto, di Bari e Bitonto. Il volume racconta il ritratto, pubblico e privato, dell’imprenditore Felice Garibaldi, fratello minore dell’“eroe dei due mondi” stabilitosi in Terra di Bari per svolgere una vantaggiosa attività commerciale nel comparto oleario. Con la sua vivacità, come quella di tanti altri forestieri che giunsero nel periodo pre-unitario a Bari e Bitonto, Felice Garibaldi s’integrò e alleò con la dinamicità e ambizione negli affari dei “negozianti” baresi (i Diana, i Milella, i Di Cagno, i Favia e i Sisto, i Calia, i Valente e i Nuzzi di Bitonto) i quali, con i nuovi traffici commerciali, incrementati da una produzione olearia più che raddoppiata, costituirono un’élite mercantile di estrazione borghese assai capace e intraprendente. La storia riflette l’abilità affaristica dell’intera famiglia Garibaldi capace di forgiare l’uomo che avrebbe unificato l’Italia e, al tempo stesso, analizza le moderne dinamiche di metà Ottocento che permisero a una fervida borghesia meridionale di costruire veri e propri imperi finanziari e le fondamenta di quella che sarebbe diventata l’economia più rilevante del Mezzogiorno. La monografia presenta, inoltre, un capitolo finale completamente dedicato all’impresa dei Mille che s’intreccia con le idee e passioni dei patrioti pugliesi e, in special modo, con quelli della Terra di Bari.
LA PRIMAVERA DEI POPOLI
La “primavera dei popoli” è un termine con il quale si identifica l’ondata di moti rivoluzionari borghesi che sconvolsero l’Europa della Restaurazione nel 1848. Si parla anche di rivoluzione del 1848 o di moti del 1848. Il suo impatto storico fu assai profondo La prima agitazione europea del 1848 è rappresentata dalla rivoluzione indipendentista siciliana che però, soprattutto a causa della sua posizione periferica, non poté rappresentare la miccia dell’esplosione europea. Tuttavia, l’insurrezione siciliana portò l’isola all’indipendenza e indusse i Borboni a concedere una Costituzione. L’esempio borbonico fu a breve seguito da Carlo Alberto di Savoia e da Leopoldo II, i quali concessero una Costituzione prima che scoppiasse l’insurrezione a Parigi. La miccia fu, invece, rappresentata dalla “campagna dei banchetti” che portò ad una rivoluzione a Parigi che, successivamente, coinvolse tutta l’Europa. Solo l’Inghilterra vittoriana, in un periodo di stabilità politica ed economica, e la Russia, in cui era praticamente assente una classe borghese capace di ribellarsi, furono esentate dalla portata distruttrice delle rivoluzioni del 1848. I fattori furono molteplici: sotto il profilo politico, sia i riformisti borghesi che i radicali si trovarono a scontrarsi con una realtà anacronistica, frutto delle conclusioni tratte durante il Congresso di Vienna, mentre sotto il profilo sociale i cambiamenti nella vita quotidiana causati dalla prima rivoluzione industriale (in Inghilterra) e la diffusione della testate giornalistiche favorirono l’ascesa degli ideali di nazionalismo e giustizia sociale anche nelle masse meno colte. La recessione economica del 1846 e il fallimento di alcuni raccolti, che portarono inevitabilmente all’inedia, furono la goccia che fece traboccare il vaso. Per quanto i moti furono sedati abbastanza velocemente, le vittime furono decine di migliaia. Gli storici concordano che la Primavera dei popoli fu, alla fin fine, soprattutto un sanguinoso fallimento. Vi furono, tuttavia, alcuni notevoli effetti a lungo termine: Germania e Italia sarebbero presto arrivate all’unificazione facendo leva anche sulla necessità di autodeterminazione dei popoli. Analogamente, l’Ungheria sarebbe giunta ad un parziale riconoscimento della propria autonomia (a discapito della popolazione slava) grazie all’Ausgleich del 1867. In Prussia e Austria fu abolito il feudalesimo, mentre in Russia fu eliminata la servitù della gleba (1861). L’anno 1848 (il quarantotto) è divenuto d’uso comune come termine indicante improvvisa confusione e scompiglio, dando origine a espressioni quali «fare un quarantotto», «combinare un quarantotto» o «è successo un quarantotto».
LISZT E I MOTI UNGHERESI
Le 19 Rapsodie ungheresi sono composizioni per pianoforte in forma libera ispirate ai moti patriottici ungheresi del 1848. Liszt scrisse questa raccolta tra gli anni 1846-53 e, poi, più tardi negli anni 1882-85, in onore dei moti rivoluzionari del democratico Lajos Kossuth per l’indipendenza dell’Ungheria dall’Austria. Le prime 15 rapsodie furono eseguite per la prima volta nel 1853, mentre le altre 4 tra il 1882 e il 1885. Per la forma l’autore si ispirò ad alcune canzoni popolari che aveva ascoltato nella nativa Ungheria: la struttura di questi brani deriva, infatti, dal verbunkos, una danza ungherese in più parti e con diversi tempi. In queste celebri composizioni, che adattò per tre diversi organici (orchestra, due pianoforti e trio), Liszt mostra tutta la sua capacità virtuosistica: vi si possono notare i contrasti tra modi e sonorità, i periodi di calma e di turbolenza e le forme libere di esposizione dei temi.
L’elegia Funérailles è il settimo brano della raccolta “Harmonies poétiques et religieuses” di Liszt, forse il più celebre, scritto dal compositore in risposta alla repressione della rivoluzione ungherese del 1848 da parte degli Asburgo. Il brano fu datato dall’autore “ottobre 1849”. Questa data è stata spesso interpretata come una sorta di omaggio per il funerale di Chopin (morto il 17 ottobre 1849), accreditato dalle reminiscenze della Polacca eroica op. 53 nel richiamo degli arpeggi della sezione centrale. Liszt spiegò, tuttavia, che il brano non fu scritto in onore di Chopin, ma in omaggio a tre suoi amici morti nella fallita rivolta ungherese contro il dominio degli Asburgo, tre vittime della rivoluzione che lacerò l’Ungheria dal 1848 al 1850: il principe Felix Lichnowsky, aggredito e ferito a morte da folle inferocite di Francoforte il 18 settembre 1848 in disordini dopo il voto sull’armistizio di Malmö, il conte László Teleki arrestato e consegnato all’Austria nel 1849 per essere stato uno dei capi della rivolta liberale della Camera ungherese, e il primo ministro d’Ungheria Conte Lajos Batthyány, giustiziato il 6 ottobre 1849 a causa del suo coinvolgimento nella rivolta. Il pezzo si compone di quattro sezioni distinte, con tre temi principali costantemente ripetuti. La prima sezione, denominata da Liszt “Introduzione”, è un triste adagio le cui battute d’apertura rappresentano un rumore sordo di campane a lato di un cupo campo di battaglia. Al tema principale, disperato, rispondono i tremoli in sforzando suonati al basso. Questo movimento oscillante, che va crescendo, è improvvisamente interrotto da un tema bellico. Nella seconda sezione il pezzo presenta una marcia funebre in fa minore che modula fino a un lagrimoso in la bemolle maggiore, basato su quinte aumentate, per poi giungere a una sorta di cupo canto di speranza. Si ascolta, quindi, una potente marcia guerriera eroica, il cui tema valoroso e trionfante è sostenuto da cascate di ottave in ostinato della mano sinistra. Questo tema cresce fino a raggiungere il culmine, per poi fermarsi improvvisamente e giungere alla conclusione nella quale vengono reintrodotti tutti i temi del brano, a partire da quello della marcia funebre, ora più potente ed enfatico. Si ribadiscono brevemente parti del tema in la bemolle maggiore, prima di riprendere la marcia guerriera a base di ottave della mano sinistra. Piuttosto che permettere alla natura selvaggia di tale tema di riprendere ancora una volta il controllo del pezzo, l’autore lo interrompe nettamente per chiudere in tranquillità.
RICCARDO RICCARDI, giornalista e saggista pugliese di antiche origini lucane, si dedica da molti anni alla ricerca storica privilegiando soprattutto gli aspetti politici ed economici del Mezzogiorno in Età moderna e contemporanea. Ha pubblicato I Pomarici - Storia di un’antica famiglia meridionale (Levante, 2003), I Pomarici di Matera - Vicende di un casato e di un palazzo (Levante, 2006), L’impresa di Felice Garibaldi - Il fratello dell’eroe dei due mondi (1835-1861) (Congedo, 2007), Album Lucano - Personaggi, famiglie e immagini ritrovate (Antezza, 2008). Collabora con le riviste “Risorgimento e Mezzogiorno” dell’Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Bari, con “Studi Bitontini” per il Centro Ricerche di Storia e Arte Bitonto, con il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. È socio del Comitato Pugliese per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
La seconda edizione del volume L’impresa di Felice Garibaldi (2010) analizza lo spaccato economico e politico sia di Nizza, patria dei Garibaldi, sia dell’intera provincia di Bari e, soprattutto, di Bari e Bitonto. Il volume racconta il ritratto, pubblico e privato, dell’imprenditore Felice Garibaldi, fratello minore dell’“eroe dei due mondi” stabilitosi in Terra di Bari per svolgere una vantaggiosa attività commerciale nel comparto oleario. Con la sua vivacità, come quella di tanti altri forestieri che giunsero nel periodo pre-unitario a Bari e Bitonto, Felice Garibaldi s’integrò e alleò con la dinamicità e ambizione negli affari dei “negozianti” baresi (i Diana, i Milella, i Di Cagno, i Favia e i Sisto, i Calia, i Valente e i Nuzzi di Bitonto) i quali, con i nuovi traffici commerciali, incrementati da una produzione olearia più che raddoppiata, costituirono un’élite mercantile di estrazione borghese assai capace e intraprendente. La storia riflette l’abilità affaristica dell’intera famiglia Garibaldi capace di forgiare l’uomo che avrebbe unificato l’Italia e, al tempo stesso, analizza le moderne dinamiche di metà Ottocento che permisero a una fervida borghesia meridionale di costruire veri e propri imperi finanziari e le fondamenta di quella che sarebbe diventata l’economia più rilevante del Mezzogiorno. La monografia presenta, inoltre, un capitolo finale completamente dedicato all’impresa dei Mille che s’intreccia con le idee e passioni dei patrioti pugliesi e, in special modo, con quelli della Terra di Bari.
LA PRIMAVERA DEI POPOLI
La “primavera dei popoli” è un termine con il quale si identifica l’ondata di moti rivoluzionari borghesi che sconvolsero l’Europa della Restaurazione nel 1848. Si parla anche di rivoluzione del 1848 o di moti del 1848. Il suo impatto storico fu assai profondo La prima agitazione europea del 1848 è rappresentata dalla rivoluzione indipendentista siciliana che però, soprattutto a causa della sua posizione periferica, non poté rappresentare la miccia dell’esplosione europea. Tuttavia, l’insurrezione siciliana portò l’isola all’indipendenza e indusse i Borboni a concedere una Costituzione. L’esempio borbonico fu a breve seguito da Carlo Alberto di Savoia e da Leopoldo II, i quali concessero una Costituzione prima che scoppiasse l’insurrezione a Parigi. La miccia fu, invece, rappresentata dalla “campagna dei banchetti” che portò ad una rivoluzione a Parigi che, successivamente, coinvolse tutta l’Europa. Solo l’Inghilterra vittoriana, in un periodo di stabilità politica ed economica, e la Russia, in cui era praticamente assente una classe borghese capace di ribellarsi, furono esentate dalla portata distruttrice delle rivoluzioni del 1848. I fattori furono molteplici: sotto il profilo politico, sia i riformisti borghesi che i radicali si trovarono a scontrarsi con una realtà anacronistica, frutto delle conclusioni tratte durante il Congresso di Vienna, mentre sotto il profilo sociale i cambiamenti nella vita quotidiana causati dalla prima rivoluzione industriale (in Inghilterra) e la diffusione della testate giornalistiche favorirono l’ascesa degli ideali di nazionalismo e giustizia sociale anche nelle masse meno colte. La recessione economica del 1846 e il fallimento di alcuni raccolti, che portarono inevitabilmente all’inedia, furono la goccia che fece traboccare il vaso. Per quanto i moti furono sedati abbastanza velocemente, le vittime furono decine di migliaia. Gli storici concordano che la Primavera dei popoli fu, alla fin fine, soprattutto un sanguinoso fallimento. Vi furono, tuttavia, alcuni notevoli effetti a lungo termine: Germania e Italia sarebbero presto arrivate all’unificazione facendo leva anche sulla necessità di autodeterminazione dei popoli. Analogamente, l’Ungheria sarebbe giunta ad un parziale riconoscimento della propria autonomia (a discapito della popolazione slava) grazie all’Ausgleich del 1867. In Prussia e Austria fu abolito il feudalesimo, mentre in Russia fu eliminata la servitù della gleba (1861). L’anno 1848 (il quarantotto) è divenuto d’uso comune come termine indicante improvvisa confusione e scompiglio, dando origine a espressioni quali «fare un quarantotto», «combinare un quarantotto» o «è successo un quarantotto».
LISZT E I MOTI UNGHERESI
Le 19 Rapsodie ungheresi sono composizioni per pianoforte in forma libera ispirate ai moti patriottici ungheresi del 1848. Liszt scrisse questa raccolta tra gli anni 1846-53 e, poi, più tardi negli anni 1882-85, in onore dei moti rivoluzionari del democratico Lajos Kossuth per l’indipendenza dell’Ungheria dall’Austria. Le prime 15 rapsodie furono eseguite per la prima volta nel 1853, mentre le altre 4 tra il 1882 e il 1885. Per la forma l’autore si ispirò ad alcune canzoni popolari che aveva ascoltato nella nativa Ungheria: la struttura di questi brani deriva, infatti, dal verbunkos, una danza ungherese in più parti e con diversi tempi. In queste celebri composizioni, che adattò per tre diversi organici (orchestra, due pianoforti e trio), Liszt mostra tutta la sua capacità virtuosistica: vi si possono notare i contrasti tra modi e sonorità, i periodi di calma e di turbolenza e le forme libere di esposizione dei temi.
L’elegia Funérailles è il settimo brano della raccolta “Harmonies poétiques et religieuses” di Liszt, forse il più celebre, scritto dal compositore in risposta alla repressione della rivoluzione ungherese del 1848 da parte degli Asburgo. Il brano fu datato dall’autore “ottobre 1849”. Questa data è stata spesso interpretata come una sorta di omaggio per il funerale di Chopin (morto il 17 ottobre 1849), accreditato dalle reminiscenze della Polacca eroica op. 53 nel richiamo degli arpeggi della sezione centrale. Liszt spiegò, tuttavia, che il brano non fu scritto in onore di Chopin, ma in omaggio a tre suoi amici morti nella fallita rivolta ungherese contro il dominio degli Asburgo, tre vittime della rivoluzione che lacerò l’Ungheria dal 1848 al 1850: il principe Felix Lichnowsky, aggredito e ferito a morte da folle inferocite di Francoforte il 18 settembre 1848 in disordini dopo il voto sull’armistizio di Malmö, il conte László Teleki arrestato e consegnato all’Austria nel 1849 per essere stato uno dei capi della rivolta liberale della Camera ungherese, e il primo ministro d’Ungheria Conte Lajos Batthyány, giustiziato il 6 ottobre 1849 a causa del suo coinvolgimento nella rivolta. Il pezzo si compone di quattro sezioni distinte, con tre temi principali costantemente ripetuti. La prima sezione, denominata da Liszt “Introduzione”, è un triste adagio le cui battute d’apertura rappresentano un rumore sordo di campane a lato di un cupo campo di battaglia. Al tema principale, disperato, rispondono i tremoli in sforzando suonati al basso. Questo movimento oscillante, che va crescendo, è improvvisamente interrotto da un tema bellico. Nella seconda sezione il pezzo presenta una marcia funebre in fa minore che modula fino a un lagrimoso in la bemolle maggiore, basato su quinte aumentate, per poi giungere a una sorta di cupo canto di speranza. Si ascolta, quindi, una potente marcia guerriera eroica, il cui tema valoroso e trionfante è sostenuto da cascate di ottave in ostinato della mano sinistra. Questo tema cresce fino a raggiungere il culmine, per poi fermarsi improvvisamente e giungere alla conclusione nella quale vengono reintrodotti tutti i temi del brano, a partire da quello della marcia funebre, ora più potente ed enfatico. Si ribadiscono brevemente parti del tema in la bemolle maggiore, prima di riprendere la marcia guerriera a base di ottave della mano sinistra. Piuttosto che permettere alla natura selvaggia di tale tema di riprendere ancora una volta il controllo del pezzo, l’autore lo interrompe nettamente per chiudere in tranquillità.
Galleria immagini
Link utili
ClioCom © copyright 2024 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati